Adolescenza problemi: i disturbi comportamentali
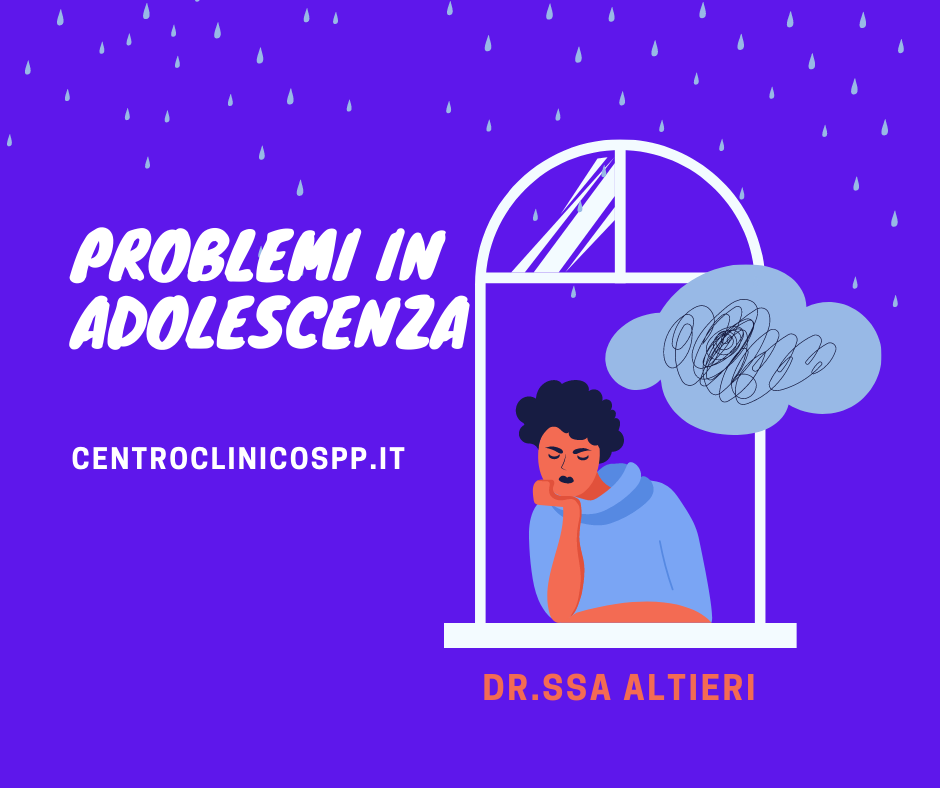
L’adolescenza, dal latino adolèscere che significa letteralmente crescere, è una fase dello sviluppo caratterizzata da molteplici cambiamenti. Il passaggio dallo stato di bambino a quello di adulto prevede una costante evoluzione e continue trasformazioni che spesso appaiono all’esterno come volubilità, instabilità e squilibrio.
L’adolescente è assalito da numerosi interrogativi e dubbi che riguardano se stesso, le trasformazioni corporee e i conflitti con i genitori. Questi cambiamenti rapidi causano una fase di disequilibrio in cui tutto viene messo in discussione. Le maturazioni repentine non sono solo in questa fase della vita, in infanzia si assiste ad un’evoluzione somatica e mentale con ritmi molto più elevati, ma la differenza è che l’adolescente è uno spettatore consapevole delle mutazioni che lo riguardano e perciò più impegnato in un difficile processo di attribuzione di senso a quello che sta accadendo.
Questi passaggi sono del tutto naturali, ma è bene prestare attenzione a quei campanelli di allarme che fanno intuire la possibilità di una patologia. Per differenziare la normalità da un possibile disturbo, sarebbe opportuno prestare attenzione all’intensità di manifestazioni di sfida, aggressività, difficoltà di autoregolazione, impulsività, scoppi d’ira ed episodi di violenza vera e propria.
Quando preoccuparsi per un adolescente?
I comportamenti adolescenziali hanno un carattere instabile e discontinuo. I ragazzi, così come i genitori, si trovano ad affrontare momenti in cui sono travolti dalla forza con la quale si manifestano alcuni comportamenti e, al tempo stesso, spaventati dalla loro violenza. I genitori, quando ciò accade, avvertono una sensazione di spaesamento, tanto da faticare a riconoscere caratterialmente il proprio figlio. Questi momenti si alternano ad altri in cui sembra essere tornata la calma, che apre uno spiraglio al dialogo e alla riflessione.
Molte volte proprio l’alternanza di fasi fa nascere nel genitore l’esigenza di chiedere un confronto con un professionista per capire meglio con quali strumenti aiutare più adeguatamente il proprio figlio ad affrontare quei momenti che provocano inevitabilmente sofferenza.
L’adolescente esprime il suo disagio attivamente attraverso la ribellione violenta fisica e verbale, e passivamente tramite isolamento e silenzio, carichi ugualmente di aggressività. A destare più preoccupazione sono segnali quali:
- - la difficoltà ad affermare la propria identità, che viene fuori quando il ragazzo o la ragazza fatica a riconoscersi;
- - la conflittualità con i genitori, percepiti come invadenti, poco comprensivi, che li trattano ancora come bambini;
- - i disturbi del comportamento alimentare o la difficoltà ad accettare il proprio corpo. I primi si presentano con l’eccesso o il rifiuto del cibo, mentre i secondi sono legati ai cambiamenti di peso, forma e altezza;
- - i problemi scolastici che si manifestano sotto forma di rifiuto e chiusura nei confronti della scuola e dello studio, oppure come insicurezze (non sono intelligente, non sono capace);
- - isolamento e difficoltà nella relazione con i pari, che vanno dal: “non voglio vedere nessuno” a “nessuno vuole stare con me, nessuno mi capisce”;
- - dubbi che riguardano l’identità sessuale e l’interesse per lo stesso sesso.
Sono tipici di questa fase ossessioni, somatizzazioni e, alcune volte, comportamenti autolesivi. Le ossessioni si manifestano con la necessità di compiere un’azione più volte, come ad esempio lavarsi spesso le mani. Le somatizzazioni si presentano con mal di testa, mal di stomaco, eruzioni cutanee che non trovano nessun riscontro medico. I comportamenti più evidenti, che destano maggiore preoccupazione, sono quelli autolesivi. Essi si presentano attraverso pensieri o agiti che riguardano il suicidio, tagli, alcool, fumo, cibo o azioni estreme che mettono in pericolo se stessi e gli altri.
Cambiamenti in adolescenza maschi vs femmine
I cambiamenti che riguardano l’adolescenza si differenziano nei maschi e nelle femmine non solo a livello fisico ma anche a livello psicologico.
- - Nei maschi con l’inizio della pubertà avvengono numerose alterazioni fisiche e psicologiche mediate dall’aumento della produzione di testosterone che porta alla crescita della barba e dei peli pubici, alla trasformazione della voce, al rafforzamento muscolare e anche alla trasformazione dei circuiti dell’ipotalamo preposti alla ricerca sessuale.
- - Per le ragazze la pubertà inizia con la comparsa del ciclo mestruale e con l’acquisizione di forme più femminili (seno, deposito di grasso sui fianchi). Gli estrogeni e il progesterone alimentano molti circuiti cerebrali sensibili a sfumature emozionali: approvazione e disapprovazione, accettazione e rifiuto.
Maschi e femmine si differenziano anche nel modo in cui si approcciano alla sessualità. Per molti ragazzi il sesso è eccitazione sessuale e soddisfacimento di un bisogno, mentre per la maggior parte delle ragazze un rapporto sessuale soddisfacente si ha con intimità e sentendosi desiderata da qualcuno che piace. Per entrambi i sessi questi cambiamenti fisici e psicologici non sono facili e comportano sentimenti di angoscia.
Come risolvere i problemi degli adolescenti?
I problemi degli adolescenti si ripercuotono inevitabilmente sui genitori, che si trovano a vivere da spettatori attoniti questo processo di maturazione. Molti di loro si imbattono in un profondo senso di impotenza per non essere in grado di aiutare il proprio figlio, unito alla rabbia quando è il figlio stesso a confermare di non sentirsi capito e compreso.
È sbagliato considerare a priori i sintomi adolescenziali in un’ottica di patologia, è più opportuno fare un’attenta valutazione e scindere ciò che è fisiologico da ciò che invece è realmente preoccupante. Per i genitori non è facile fornire allo stesso tempo presenza emotiva e sana distanza che porti all’autonomia e all’identificazione. I genitori che riescono a porsi in modo più sereno aiutano meglio i figli a stabilire dei legami esterni con il gruppo dei pari senza sentirsi in colpa.
Quando le preoccupazioni sono elevate è sempre opportuno rivolgersi ad uno psicologo-psicoterapeuta in modo da comprendere meglio la dinamica e trovare una soluzione adeguata alla problematica. È difficile, infatti, che un adolescente decida in autonomia di andare da uno psicoterapeuta, il più delle volte l’idea arriva dai genitori, e non è scontato che accetti e decida di continuare.
Quando si prende un adolescente in terapia, si prendono in carico anche i genitori, il confronto con essi è fondamentale. In base alla situazione si valuterà se lavorare solo con i genitori per aiutarli nella fatica e supportarli nel loro ruolo, con i genitori e con l’adolescente, oppure solo con l’adolescente.
Se desideraste contattarmi, cliccate sulla pagina dedicata ai contatti e compilate il form. Vi ricontatteremo con immediatezza.
Dr.ssa Annunziata Altieri - Centro Clinico SPP Milano

